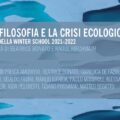Questo articolo fa parte di una serie di contributi connessi agli incontri tematici su Crisi ecologica e crisi climatica iniziati il 15 gennaio che abbiamo pensato di organizzare per approfondire uno dei grandi problemi di oggi. Siamo partiti dal presupposto che i limiti planetari a rischio di superamento (o già superati) sono più d’uno, tutti correlati tra loro, mentre il capitalismo green (pur sembrando appellarsi alla scienza) tende a ridurre tutta la questione ecologica alla sola questione climatica, e riduce poi la questione climatica alla sola questione energetica, da risolvere in modo lineare mediante la sostituzione tecnologica delle fonti di energia fossile con quelle rinnovabili e l’elettrificazione degli usi finali. Per noi è ovviamente imprescindibile l’abbandono delle fonti non rinnovabili, ma non è sufficiente.
Impianti eolici industriali in Toscana: vale il sacro principio T.I.N.A. There Is No Alternative, ce lo ha ricordato l’assessora Monia Monni in questi giorni. Ma nessuna paura: gli impianti, ci dicono, saranno accuratamente selezionati in base a progetti di qualità. Come sapete l’assessora sta parlando di progetti privati a cui verrà dato il suggello di pubblica utilità con il conseguente diritto di esproprio di terreni in aeternum a favore dei proponenti, perché questo è il meccanismo cosiddetto di mercato “che vuole l’Europa”. Il progetto eolico Giogo di Villore viene citato dall’Assessora appunto come esempio. Così ora ci possiamo fare un’idea esatta di che cosa significa progetto eolico industriale di qualità secondo la Regione Toscana. Un progetto che è stato portato avanti contro il parere negativo del Parco delle Foreste Casentinesi e della Soprintendenza e di cui abbiamo già scritto su la Città invisibile.
Lo scivolamento verso un solo possibile esito, cioè lo sconvolgimento del paesaggio, l’erosione della biodiversità, è per così dire nell’aria, oltre che nelle leggi, è nella narrazione dominante, è nelle azioni della finanza, è un tarlo che scava nella testa dei cittadini, come in quella dei giudici amministrativi, come dei politici regionali, dei giornalisti.
E se davvero questa è l’unica via per fermare il riscaldamento climatico? O più esattamente: l’unica per rallentarlo in modo che non raggiunga i punti di non ritorno?
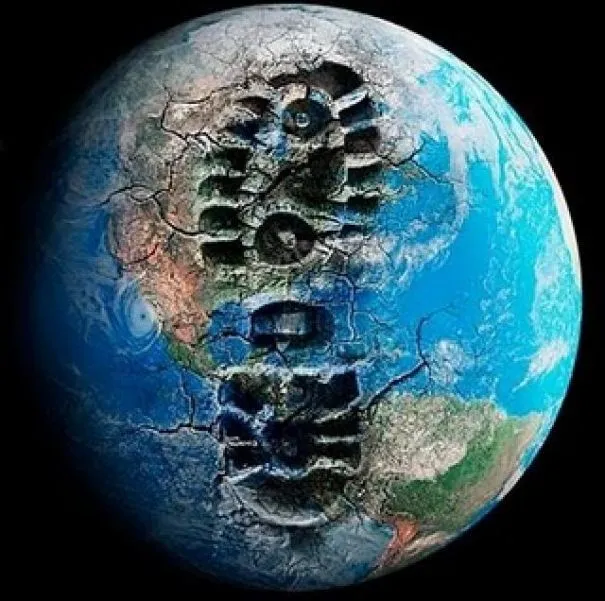
E’ difficile pensare quando ogni giorno fior di professori ci presentano scenari prospettici ricavati da simulazioni operate su modelli matematici che non siamo in grado di capire, e ci dicono che però dobbiamo fidarci perché ne va del futuro della specie umana, e che quelle simulazioni significano che la salvezza ci sarà solo se ora, subito, entro pochi anni, elettrifichiamo tutto e costruiamo turbine eoliche e impianti fotovoltaici dappertutto. Poi ci viene un brivido con il sospetto che in realtà anche i decisori politici non fanno altro che ripetere quello che gli viene presentato dai supertecnici, senza autonomia di pensiero.
Ma come, allora non è giusto avere fiducia nella scienza? E una paradossale domanda questa, perché il metodo della scienza è appunto quello di non basarsi sulla fiducia e tantomeno sul fideismo. Tuttavia, certo, è corretto considerare anche un principio di verosimiglianza nel sapere: si deve (provvisoriamente) considerare vero quello che fa parte del consenso scientifico del nostro tempo. Nessuna concessione alle elucubrazioni da bar, al pensiero magico e alle teorie fai-da-te, siamo d’accordo. Ma neanche possiamo rinunciare alla nostra elementare sovranità di cittadini per consegnarla ai tecnocrati e agli amministratori di turno. La sovranità si esercita sulle scelte, che presuppongono l’esistenza di opzioni alternative e della possibilità di pensare in modo autonomo. Il consenso scientifico sulle prospettive e le cause del riscaldamento globale va tenuto presente da tutti, fino a prova contraria, ma la scelta delle risposte appartiene alla politica e non può essere affidata a un pensiero unico.
E la verifica che esistono alternative, e quindi è possibile un modo di pensare autonomo sulle risposte da dare al riscaldamento globale causato dalle emissioni, è per così dire immediata, basta fare un piccolo esercizio mentale che consente di uscire dall’ipnotismo della narrazione dominante. Lo stesso numero di tonnellate di CO2 che si prevede di risparmiare in Toscana costruendo impianti industriali di energie rinnovabili ad alto impatto sull’ambiente, e anche molte molte tonnellate di più, potrebbero essere risparmiate limitando le attività ad alta emissione che avvengono sul territorio toscano, a cominciare dalla base militare di Camp Darby, i voli su aerei privati, l’estrazione del marmo. Avanti con le idee!
Una parte potrebbero essere risparmiate fermando completamente il consumo di suolo e distribuendo per esempio d’autorità le case vuote alle persone senza casa, senza più costruzioni nuove.
Una parte potrebbero essere risparmiate mediante lo sviluppo impetuoso delle comunità energetiche rinnovabili, le CER, cioè dirottando su queste gli incentivi in modo veramente massiccio e non asfittico come ora, e creando procedure estremamente facilitate e sburocratizzate con il sostegno pubblico.
E infine, una parte di emissioni potrebbero essere risparmiate anche costruendo turbine eoliche, ma con investimenti pubblici sottratti all’obbligo concorrenziale capitalistico della ricerca della massima redditività, quindi rispettando per esempio la regola delle linee guida nazionali di privilegiare la scelta di siti già industriali. Cosa che i privati non si sognano di fare, perché il loro driver è il profitto.
Questo si può pensare e dire d’acchito. Ora vediamo però anche un altro aspetto, una domanda da cento punti per il futuro umano.
E’ davvero realistica, è “tecnicamente possibile” la decarbonizzazione toscana, europea, planetaria affidata a questi strumenti essenzialmente tecnologici che compongono la cosiddetta transizione energetica e che sono: le fonti di energia rinnovabile, i (futuristici) sistemi di accumulo, l’elettrificazione degli usi finali, l’efficientamento energetico?
Attualmente gli impianti di energie rinnovabili, pannelli, turbine ecc. vengono fabbricati e trasportati, installati facendo essenzialmente ricorso all’energia prodotta con le fonti fossili. Nessuno è in grado di dire se e quando si cominceranno a fabbricare usando energia prodotta a sua volta da fonti rinnovabili. Esiste poi il problema grandioso degli scavi minerari e delle materie prime rare o anche non rare ma di prima necessità.
E’ di questo gennaio 2025 un avviso della Agenzia Internazionale dell’Energia (organo non dell’Onu, ma dell’OCSE quindi voce sincera dal seno del capitalismo). Secondo gli scenari prospettici nel 2035 la domanda di rame dovrebbe superare l’offerta del 30%. Si può immaginare con quale effetto sui prezzi.
Un singola insidiosa notiziola non basta per far crollare un’intera dottrina della transizione, d’accordo. Ma quella che segue non è una notiziola.
Secondo i dati sempre dell’Agenzia internazionale dell’Energia, tra il 1971 e il 2021 l’energia proveniente da fonti rinnovabili si è più che triplicata in termini assoluti. Tuttavia, a causa dell’enorme aumento della domanda globale di energia, l’aumento del tasso percentuale di energia proveniente da tali fonti non fossili è stato deludente: dal 12,9% al 14,7% dell’energia primaria totale nello stesso periodo. (NOTA).
Dunque non siamo di fronte a una transizione energetica, ma a una espansione energetica e una addizione di fonti energetiche differenti. L’area europea è l’unica in cui si sia verificato un notevole calo percentuale delle emissioni, ma il sospetto è che questo calo dipenda soprattutto dalla contemporanea deindustrializzazione del continente. Quindi da un trasferimento delle emissioni.
L’efficientamento energetico poi merita un discorso a parte. E’ un insieme di processi di miglioramento tecnologico di notevole importanza e di grandi potenzialità, che permette di ottenere prodotti e servizi che a pari di quantità di prodotto consumano meno energia e/o materie prime. Avviene sotto lo stimolo della concorrenza, prevede uno stretto rapporto tra ricerca e produzione e in queste cose il capitalismo è piuttosto bravo. Però sempre nel bravo capitalismo il vantaggio ambientale dell’efficientamento può essere annullato dal famigerato effetto rimbalzo (detto anche paradosso di Jevons): in una società basata sull’espansione economica il vantaggio di aver ridotto il consumo energetico mediante l’efficientamento, e la discesa relativa del prezzo, portano a utilizzare maggiormente la tecnologia in questione, vanificandone il risparmio energetico e quindi gli effetti benefici sulle emissioni.
Di conseguenza sulla crisi ecologica si deve ragionare con una visione a 360 gradi che tenga conto della complessità.
Il riscaldamento climatico è uno degli aspetti di una crisi più ampia causata dall’ artificializzazione della biosfera, in un certo senso è solo un sintomo. Ogni intervento infrastrutturale, anche il meglio intenzionato, rischia di far aumentare la dimensione e la voracità di quello che l’ecologista Nate Hagens chiama Superorganismo economico, un’entità mostruosa e priva di anima che si espande senza pensare.
C’è bisogno anche di interventi sul sintomo, ma non sarà la tecnologia in quanto tale a salvarci, anzi agirà al contrario, se alimenta il Superorganismo. Per esempio le energie rinnovabili sono utili se vanno a sostituirsi a quelle fossili; dannose, se si addizionano alle prime per stare dietro alla domanda crescente di energia.
In attesa di una economia che funzioni in un altro modo, serve resistere alla fame di risorse del Superorganismo, tenendo bene gli occhi puntati sul consumo globale di energia, di suolo, di materie prime, di tempo di vita. E avere il coraggio di pensare.
NOTA vedi Sean Sweeney, John Treat e Daniel Chavez, Energy Transition or Energy Expansion?, New York e Amsterdam: Transnational Institute, citato da Lorenzo Feltrin Il piano verde del capitale: Crisi e direzioni alternative, (2021).
Questi dati possono ora essere verificati e aggiornati per esempio sulla base dell’ultimo rapporto dell’Energy Institute dove a pag. 12 troviamo che nel 2023 l’energia primaria da fonte fossile usata è scesa sì in percentuale dall’ 81,9 % dell’anno prima all’81,5 %, ma in termini assoluti è cresciuta a causa della crescita globale di domanda di energia, per cui le emissioni di gas serra da produzione energetica hanno raggiunto un nuovo spaventoso record.
Paolo Chiappe
Ultimi post di Paolo Chiappe (vedi tutti)
- Crisi climatica: considerazioni per pensare in modo autonomo - 18 Gennaio 2025
- Toscana da eolizzare per salvare il pianeta? - 12 Dicembre 2023
- “Energia verde? Prepariamoci a scavare”, di Giovanni Brussato - 22 Marzo 2021