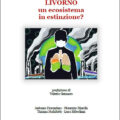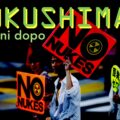Sono state due giornate dense e molto utili quelle organizzate dal CSA Next Emerson di via Bellagio a Firenze, dedicate all’incontro di realtà in lotta sui diversi territori e alla costruzione di strumenti comuni e percorsi concreti.
Il lavoro si è articolato in tre tavoli tematici: mobilità e accesso alla città, ovvero mobilità verso le periferie e territori isolati, politiche di esclusione e servizi delegati a privati; consumo di suolo, cementificazione, dissesto idrogeologico, difesa dei territori dalle devastazioni ambientali; emergenze, ossia prevenzione e gestione autogestita dei disastri, rafforzamento della solidarietà dal basso. Infine, un’assemblea finale ha fornito la restituzione del lavoro dei tavoli a cui hanno partecipato più di 20 realtà locali e non.
 Il primo tavolo è iniziato con la sottolineatura di un dato di fatto: l’ambiente urbano è ormai inteso come perpetua fonte di speculazione e profitto; a tal proposito è stato notato che, negli ultimi 25 anni, questa tendenza è passata dall’essere occasionale (l’eccezionalità del malaffare di singoli) a diventare strutturale (le speculazioni vengono ormai progettate e pianificate). Conseguentemente è emersa la necessità di distinguere due piani di reazione paralleli e fondamentali: quello rivendicativo e quello della condivisione di saperi e strumenti. Pur riportando l’esistenza di un inevitabile “effetto di scala” che restituisce la percezione delle lotte dal basso come delle mosche bianche di fronte ai giganti dei fondi finanziari internazionali, nulla vieta a tali resistenze di essere mosche bianche fastidiose, che, grazie allo sviluppo sincrono della rivendicazione e dell’incremento dei propri mezzi teorico-pratici, possono spingere l’amministrazione pubblica a dover rispondere delle proprie responsabilità.
Il primo tavolo è iniziato con la sottolineatura di un dato di fatto: l’ambiente urbano è ormai inteso come perpetua fonte di speculazione e profitto; a tal proposito è stato notato che, negli ultimi 25 anni, questa tendenza è passata dall’essere occasionale (l’eccezionalità del malaffare di singoli) a diventare strutturale (le speculazioni vengono ormai progettate e pianificate). Conseguentemente è emersa la necessità di distinguere due piani di reazione paralleli e fondamentali: quello rivendicativo e quello della condivisione di saperi e strumenti. Pur riportando l’esistenza di un inevitabile “effetto di scala” che restituisce la percezione delle lotte dal basso come delle mosche bianche di fronte ai giganti dei fondi finanziari internazionali, nulla vieta a tali resistenze di essere mosche bianche fastidiose, che, grazie allo sviluppo sincrono della rivendicazione e dell’incremento dei propri mezzi teorico-pratici, possono spingere l’amministrazione pubblica a dover rispondere delle proprie responsabilità.
Per quanto riguarda la mobilità, uno dei nodi centrali affrontati durante il tavolo coincide con la necessità di definire nuove metriche per la sua gestione. Il trasporto pubblico non deve continuare a privilegiare i centri storici, le zone più “ricche”; bensì, deve essere capace di erogare i propri servizi ai singoli quartieri, alle aree periferiche, nel quadro di una visione socialista dello spazio in cui i luoghi non sono ridotti a merce. Sono state poi avanzate proposte più pratiche, come la creazione di strumenti di mappatura dei luoghi di due tipi: il primo per favorire l’individuazione delle criticità da parte dell3 attivist3, il secondo rivolto all’esterno. L’idea è quella di dar forma ad una “mappa poco capitalista”, nella quale è evidenziata la presenza/l’assenza di centri sociali, ciclofficine, ambulatori popolari, presidi sanitari accessibili dal basso; in questo senso, lo specchietto dei servizi per i senza dimora su Fuori Binario è un buon esempio – i migranti usano tantissimo questo strumento. È stato riportato che strumenti simili esistono ma non funzionano; esiste già, ad esempio, una mailing list degli ambulatori popolari italiani che devo però essere riattivata. In generale, il tema dello sviluppo di nuove piattaforme di comunicazione è trasversale ai tavoli.
Tornando alle “mappe poco capitaliste”, è fondamentale che siano elencati anche i servizi che mancano. Per realizzare questo sono stati immaginati più layers: oltre a quello dei servizi attivi, ci deve essere anche il filtro dei servizi che sono stati soppressi, dei servizi che non sono stati nemmeno progettati. A Quarticciolo, nella periferia orientale di Roma, è stata fatta una mappa delle case popolari che evidenzia i luoghi su cui è necessario intervenire, lo storico degli interventi effettuati e le nuove misure richieste; di fatto, è una contromappatura di quella ufficiale. Grazie a questo, è stato possibile sbattere in faccia all’amministrazione la penuria di manutenzione. La trasparenza della cosa pubblica, dal punto di vista dei piani dal basso, è opaca. Per architettare un simile progetto, che sia pure capace di garantire la veridicità delle fonti, sono richieste molte risorse e energie, ragion per cui inizialmente deve essere pensato su base locale.
Il tavolo sul consumo di suolo e cementificazione è stato molto vivo, probabilmente quello col taglio più pragmatico. Incentrandosi più sulle aree extra-urbane, il lavoro del tavolo è partito dalla seguente intuizione: seguire il flusso delle acque. Seguirle a partire dalle montagne, per prevedere come l’acqua scende verso valle a seconda del territorio che incontra; troppo spesso, infatti, ci si dimentica che i danni a valle si originano dall’alto. Per riconoscere i sintomi di un reticolo idrogeologico alterato è necessario recuperare le competenze e ripristinare le tecniche che aiutavano a contenere le acque (si pensi alla dimenticata costruzione dei muri a secco, oggi sostituiti da muri cementificati). A tutto ciò si ricollega anche il tema del cambiamento climatico e degli eventi metereologici estremi, dietro cui si giustifica l’assenza di manutenzione ordinaria e di programmazione futura. La questione della manutenzione è essenziale: è fondamentale organizzare momenti collettivi di condivisione di pratiche manutentive. È stato poi affrontato l’aspetto legato al ripopolamento dei territori, assai spinoso e problematico, considerato che un ripopolamento “casuale” (che ripropone certe dinamiche cittadine) non è funzionale. La montagna ha bisogno di ospitare un nuovo tessuto sociale: come tessere nuove trame all’interno di questi luoghi? Forse si deve pensare più al concetto di ri-radicamento, piuttosto che alla nozione di ripopolazione. Ed è importante farlo: più i luoghi sono abbandonati, più sono soggetti alla bieca speculazione. (Divagazione sul tema: si crea prima la resistenza, o si crea prima la comunità? L’ideale sarebbe che le due cose si rafforzassero l’un l’altra. Se si perde una lotta ma non c’è una comunità, si rimane a mani vuote; se invece c’è una comunità, una sconfitta può essere l’occasione di rafforzamento e crescita della lotta successiva).
Per quanto riguarda le zone urbane, è stato affrontato il tema del verde pubblico. Un importante passo in avanti sarebbe l’attuazione di un nuovo regolamento urbanistico che dichiari per tutte le aree verdi – pubbliche e private – nuovi requisiti di “permeabilità ecologica” (in riferimento alla cosiddetta legge Marson della Regione Toscana). Lo sforzo da compiere, attraverso un’operazione di mappatura, è quello di individuare queste aree e sottoporle all’attenzione dell’amministrazione pubblica. Sempre a proposito di città, è stata registrata la necessità di invertire una pericolosa abitudine indotta dalle recenti speculazioni inerenti al consumo del suolo. Il cui diabolico mantra recita: “dove c’è spazio si deve costruire, per non avere terrore del vuoto”.
Dal tavolo sulle emergenze sono emerse alcune domande: come “dare continuità”? Cosa fare tra un’emergenza e l’altra? Come dotarsi degli strumenti utili per evitare che le emergenze accadano? La continuità consiste nella ripresa di responsabilità dirette ed individuali, riappropriandosi del ruolo di manutentori del posto. La continuità si costruisce mantenendo costante il supporto alle organizzazioni sociali dal basso: a Valencia, se non fosse già esistita una rete, sarebbe stato un disastro. Lo spontaneismo è certamente un wishful thinking, ma è un dato di fatto: negli spazi dove esistono realtà già consolidate c’è un grande margine di operatività. È importante tenerne di conto, soprattutto in un momento storico in cui c’è tanta disillusione su dove possa arrivare lo Stato; la sensazione condivisa è che lo Stato non riesca ad essere dove dovrebbe. Questi vuoti devono essere riempiti dal basso? Deve essere sollecitato un rientro in scena dello Stato? Un altro dato di fatto è che i vuoti sono momenti fertili per la riappropriazione di pratiche autogestione.
Nelle Conclusioni della due giorni è venuta a galla la difficoltà incontrata nel raggiungere molte delle realtà che avrebbero potuto partecipare con competenza a Tellurica. Questo dimostra quanto il lavoro dal basso nei vari ambiti, pur nel solco di ideali e scopi comuni, sia parcellizzato, atomizzato. Ciò sottolinea pure l’esigenza dell’ideazione di nuovi strumenti per far conoscere certe pratiche dal basso al di fuori della singola esperienza, onde evitare il rischio che ogni realtà, non avvalendosi dell’esperienza di altri, riparta faticosamente e inutilmente da capo. Continuare Tellurica è un’occasione per tentare di colmare questa lacuna. Sul piano pratico sorge il bisogno di avere un sito di Tellurica, per un’iniziale contaminazione del territorio; per una più generale rete di servizi che possa agevolare scambi di esperienze, attivare momenti di formazione, mettere a disposizione materiali di approfondimento e fornire strumenti condivisi per un supporto tecnico e legale per le lotte.
Lorenzo Robin Frosini
Ultimi post di Lorenzo Robin Frosini (vedi tutti)
- Tellurica, due giorni di studio e condivisione: un report - 18 Febbraio 2025
- A Firenze presidio sotto il rettorato: no alla complicità dell’Università con l’industria bellica - 21 Gennaio 2025
- Minacce globali alla libertà di espressione - 2 Gennaio 2025